Perché Rousseau era un Gilet giallo
- Dettagli
- Visite: 5940
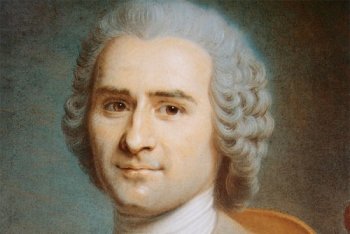 Intervento, 27 dicembre 2018 - Invece di leggere Rousseau, si preferisce farne la caricatura. Lo si presenta come un mite sognatore con illusioni campestri, buono solo a suscitare fervori prepuberali (l'immagine è di Jean-Jacques Rousseau)
Intervento, 27 dicembre 2018 - Invece di leggere Rousseau, si preferisce farne la caricatura. Lo si presenta come un mite sognatore con illusioni campestri, buono solo a suscitare fervori prepuberali (l'immagine è di Jean-Jacques Rousseau)
Le Grand Soir, 21 dicembre 2018 (trad.ossin)
Perché Rousseau era un Gilet giallo
Bruno Guigue
Invece di leggere Rousseau, si preferisce farne la caricatura. Lo si presenta come un mite sognatore con illusioni campestri, buono solo a suscitare fervori prepuberali. Nella migliore delle ipotesi, sarebbe un preromantico i cui libri si coprono di polvere negli scaffali delle biblioteche. Nelle peggiore, un illuminato, un tipo ultrasensibile, uno psicopatico, i cui funesti principi sarebbero alla base del totalitarismo. Vilipendere questo plebeo, questo paria della filosofia perso in un secolo di fortunati gaudenti, rientra in una tradizione di lunga data. Mirabilmente Henri Guillemin ha posto in evidenza la profonda solitudine di Jean-Jacques all’ombra dei Lumi. «Rousseau, nel XVIII secolo, è l’uomo che dice apertamente, della società così come è, tutto quanto non si dovrebbe dire quando si è bene educati e si aspiri ad una carriera. Non si accontenta di esasperare gli Enciclopedisti con le sue parole sull’anima, su Dio, sulla fine dell’uomo, ma li terrorizza anche, e li spaventa, parlando senza rispetto dei grandi e dei ricchi. Non siamo molto inclini, dal punto di vista filosofico, a considerazioni di questo tipo. La setta, direbbe Robespierre, ha talvolta criticato il dispotismo, ma i suoi membri hanno fatto di tutto per ottenere una pensione dai despoti. D’Holbach, Helvétius, appartengono all’alta borghesia finanziaria».
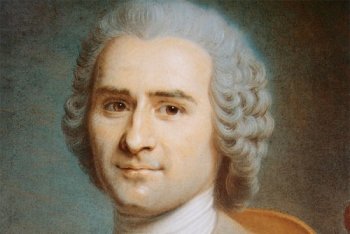
Gli Enciclopedisti hanno riservato a Rousseau il loro disprezzo, Ma Voltaire non era da meno. «E’ scivolato con le sue speculazioni, scrive Guillemin, nella classe agiata e non ha mai voluto che il sistema venisse messo in discussione. Per lui, operai e contadini sono la plebe, e il primo dovere dei lavoratori è di mantenersi muti in quella laboriosa servitù che alimenta i ricchi». Rousseau? Per Voltaire, è un pezzente che vorrebbe che i ricchi venissero derubati dai poveri. Quel che la borghesia detesta in lui «è l’uomo del Discours sur l’inégalité e del Contrat social, libri – scrive Mallet du Pan - che furono il Corano degli oratori del 1789. Nessuno scrittore è più in grado di lui di rendere superbo il povero, notava Joubert il 15 aprile 1815. E Brunetière insisteva, con una punta di disgusto, sul nauseante pedigree di Rousseau: i genitori di Rousseau erano popolo, nel senso più infelice del termine; la volgarità delle sue origini è il primo tratto del suo carattere. Nel momento culminante della reazione borghese, dopo quelle giornate del 1948 che «lo riempirono di timori», Sainte-Beuve travolse Rousseau col suo disprezzo di classe. «Rousseau è stato un lacché, disse, aggiungendo con finezza: Si percepisce. Taine, all’indomani della Comune, riscontrò in tutto il pensiero di Rousseau nient’altro che un rancore plebeo, povero, amareggiato, di chi, entrando nel mondo, ha trovato tutti i posti occupati e non ha saputo farsi strada; riesce a non invidiare solo denigrando» (Henri Gullemin, Du contrat social, Présentation, UGE, 1973).
E se questo odio per Rousseau fosse la migliore testimonianza in favore della sua filosofia, dimostrando che non solo era un passo avanti rispetto al suo tempo, ma anche rispetto al nostro, e che non poteva sfuggire al destino di restare isolato attaccando l’ingiustizia su tutti i fronti? Non era solo la sua singolare psicologia a spingere Rousseau contro una società consunta, ma proprio il suo pensiero più profondo, il suo sistema filosofico. Che detestava la borghesia per il suo egoismo rapace, per i suoi costumi depravati: la sua filosofia odiava la borghesia per le sue idee. La sua epoca, egli la definiva in una lettera al Mercure come «un secolo di ciarlatani nel quale i più grandi mascalzoni hanno sempre l’interesse pubblico nella bocca». E nell’Emile, lanciava questo avvertimento: «Vi affidate all’ordine attuale della società senza pensare che questo ordine è soggetto a inevitabili rivoluzioni». La sua filosofia, è noto, prevedeva la Rivoluzione francese. Ma bisogna fare attenzione a non attraccare Rousseau al porto della borghesia in ascesa. Il rigore del suo pensiero trascinava il filosofo-paria molto lontano da queste sponde rassicuranti. E se ha alimentato col suo pensiero il processo rivoluzionario, ha soprattutto previsto l’usurpazione di questo processo da parte della borghesia.
Una filosofia della libertà
Quale è la sua filosofia? Un principio ne fornisce la linea guida: che si tratti di educazione o di governo, egli condanna come contrario alla natura tutto ciò che viola la libertà dell’uomo. La libertà è davvero la qualità nativa dell’uomo, essa costituisce la «dignità del suo essere». E’ sempre questo che intende dire quando afferma nel Contrat social che l’uomo è «nato libero» o quando scrive nel Discours sur l’inégalité : «non è tanto l’intelligenza che distingue specificamente l’uomo tra gli animali, quando il suo essere un agente libero». Ma partiamo dall’inizio. Scopriamo l’uomo della natura nascosto sotto l’uomo dell’uomo. Per tornare al vero stato di natura dobbiamo fare astrazione dall’uomo sociale, bisogna rappresentarsi l’uomo nel suo stato nativo, così come è uscito dalle mani della natura, avvolto nella sua innocenza originaria. Affidandosi alla antropologia-fiction, bisogna immaginare gli uomini dispersi, sparpagliati nelle foreste. Questo stato di isolamento è una fiction, ma ci è indispensabile se si voglia «ben valutare il nostro stato presente». In un simile stato di isolamento, l’uomo gode dell’indipendenza più completa perché è autosufficiente. Niente e nessuno potrà asservirlo. Nessun legame di dipendenza esiste tra un uomo ed un altro nello stato di natura, ed è sotto questo profilo che questo stato è esemplare.
Intendiamoci, la fiction filosofica dello stato di natura non descrive affatto uno stadio anteriore dell’umanità. Essa ha la funzione teorica di sottolineare la libertà naturale: nessun uomo è naturalmente fatto per comandare o obbedire. L’oppressione che caratterizza le società diseguali non è una fatalità, ma un fenomeno contingente. Che degli uomini sottomettano altri uomini è un fatto storico e non una necessità propria della specie. La descrizione dello stato di natura sottolinea dunque la condizione servile che è propria dello stato sociale. Ma l’uomo civile non è solo sottomesso alla volontà di altri uomini, il povero alla volontà del ricco, lo schiavo a quella del padrone. C’è anche, nello stato civile, un servaggio morale, la sottomissione all’opinione e al pregiudizio. Lungi dal giudicare da se stesso, l’uomo civile ha una sola preoccupazione, quella di conformarsi all’opinione degli altri. In senso stretto, lo stato civile è sinonimo di alienazione: è dallo sguardo degli altri, questo fermento di corruzione, che l’individuo trae il senso della propria esistenza.
E’ per questo che il passaggio dallo stato di natura allo stato civile comporta la perdita della libertà. Questo passaggio dallo stato naturale allo stato sociale non era ineluttabile, ma è irreversibile. Contrariamente a quanto talvolta si dice, in Rousseau non c’è alcuna nostalgia di un’età d’oro perduta. Egli sa bene che la cultura ha oramai completamente avvolto la natura e che questa trasformazione ha strappato l’umanità allo stato animale. Per contro, la perdita della libertà che è conseguenza dello stato sociale non è ineluttabile. Se questa perdita fosse definitiva, si tratterebbe di una condanna senza appello della società civile. Ma società e libertà non si escludono irrimediabilmente. Le opere politiche di Rousseau mostrano al contrario che l’uomo, dotandosi di istituzioni appropriate, può guadagnare l’equivalente di quel che ha perso abbandonando lo stato di natura. Può convivere coi suoi simili senza dover sacrificare la sua libertà, perché può trovare nella società l’equivalente civile della sua libertà nativa.
Il regno della legge
Il problema posto dal Contrat social è precisamente quello di istituire l’autorità politica senza che ciò avvenga a scapito della libertà dell’uomo. L’uomo diventato cittadino deve restare «libero come prima», dice Rousseau. E’ possibile? Sì, «se ognuno fa col patto sociale uno scambio tra la sua libertà naturale contro la libertà civile e la libertà morale» (Contrat social, I, 8). Queste due forme di libertà sono forgiate dall’educazione e la cultura, sono libertà riconquistate attraverso una forma di sottomissione. Per Rousseau, la libertà non è capriccio: essa non è una funzione del desiderio, ma un effetto della legge, è esigenza e non piacere. Se la filosofia di Rousseau non piace alla borghesia, è perché non è liberale: l’unica libertà che ci è accessibile è quella del cittadino, e non dell’individuo. Essa passa per la sottomissione alla legge comune e non all’interesse privato. La libertà è una conquista dell’uomo su se stesso: essa stimola le sue più nobili facoltà e le eleva a virtù.
Ma come si può restare liberi pur obbedendo alla volontà generale? Non si tratta solo di una sottomissione volontaria o consentita. «Ogni uomo, essendo libero, è padrone di se stesso, niente per nessuna ragione può assoggettarlo senza confessarlo». E’ così – e soprattutto – perché l’obbedienza alla volontà generale garantisce il cittadino da qualsiasi dipendenza particolare. La legge libera il debole dalla dominazione del potente, essa vieta qualsiasi soggezione dell’uomo da parte dell’uomo. «La libertà consiste meno nel realizzare la propria volontà che nel non essere sottomesso a quella di altri». Nello stato civile legittimo, il cittadino «obbedisce solo alle leggi, ed è per la forza delle leggi che non deve obbedire agli uomini». Obbedire ad un uomo significa avere un padrone, mentre sottomettersi alla volontà generale significa sottomettersi ad una autorità impersonale che non saprebbe sopprimere la libertà.
Ma non confondiamo il fatto e il diritto. «Nei fatti, le leggi sono sempre vantaggiose per i possidenti e vessatorie verso chi non ha niente», ricorda Rousseau. La storia insegna che le leggi sono fatte per i ricchi. Maledizione dello stato sociale, questa diseguaglianza è inevitabile? No, perché nel Contrat social Rousseau indica le condizioni perché la legge sia veramente legge, vale a dire espressione della volontà generale. La legge così intesa è un ideale, beninteso, del quale le leggi esistenti sono parodie grottesche. Ma la filosofia politica di Rousseau non avrebbe alcun senso se non prefigurasse la possibilità di un’altra società. Nello stato civile legittimo – che è ancora da costruire – la legge non è più lo strumento del ricco: essa è espressione del popolo, incarna l’interesse comune. Obbedendo alla volontà generale, il cittadino obbedisce solo a se stesso. Perché la volontà generale non è per lui una volontà estranea, ma la sua stessa volontà, se non come uomo, almeno come cittadino, vale a dire come parte di un tutto. «La volontà costante di tutti i membri dello Stato è la volontà generale, è grazie ad essa che essi sono cittadini e liberi» (Contrat social, IV, 2).
La legge del popolo
Ma perché la legge sia una vera legge, vale a dire l’espressione dell’interesse comune, che occorre fare? La risposta di Rousseau è semplice: bisogna che sia il popolo a fare le leggi. «La sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per la quale essa non può essere venduta, essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e della volontà non ci può essere rappresentanza (..) I deputati del popolo non sono dunque, né potrebbero essere, i suoi rappresentanti, non sono altro che commissari; non hanno il potere di decidere niente definitivamente. Ogni legge che il popolo in persona non abbia ratificato è nulla; non è affatto una legge. Il popolo inglese pensa di essere libero, si inganna del tutto; lo è solo durante l’elezione del membri del Parlamento: appena questi sono eletti, esso è di nuovo schiavo, è ancora una volta niente. Nei brevi momenti di libertà, l’uso che ne fa merita bene che la perda» (Contrat social, III, 15). La volontà generale è l’esercizio stesso della sovranità, ed è ciò che ne rende impossibile la rappresentanza. Perché che cosa significherebbe in realtà «rappresentare» la volontà? Sarebbe ammettere che qualcuno possa volere per un altro. E’ una cosa filosoficamente impossibile: la volontà è ciò che in qualsiasi uomo appartiene solo a lui, è la manifestazione irriducibile della sua libertà. «Il principio di ogni azione è nella volontà di un essere libero, non si può andare al di là» (Emile, IV).
Il ragionamento è inarrestabile: essendo la sovranità una volontà, ed essendo la volontà per sua intima essenza non rappresentabile, anche la sovranità non può essere legittimamente rappresentata. Che il popolo voglia o che non voglia, non sono possibili mezze misure. Se dei rappresentanti possono esprimersi a nome tuo, questa rappresentanza deformerebbe la volontà popolare. Introdurrebbe sfumature che ne altererebbero la purezza, rispondendo a questo o a quell’interesse particolare. In realtà, la volontà dei rappresentanti si sostituirebbe a quella dei rappresentati. Ma se la sovranità non è suscettibile di rappresentanza, è perché la volontà è generale. Siccome è una volontà generale, la sovranità detta la legge, ma non la applica. Pura volontà, la volontà generale non può essere delegata. Solo il potere esecutivo, incaricato dell’applicazione della legge, può essere delegato, perché si tratta di stabilire le condizioni di applicazione della legge ai casi particolari.
E perciò i «deputati del popolo», detti anche suoi rappresentanti, non possono essere che semplici «commissari», esecutori investiti di una missione strettamente definita. «Non possono prendere decisioni definitive. Qualsiasi legge che il popolo in persona non abbia ratificato è nulla, non è affatto una legge». Solo il popolo è sovrano, perché la volontà generale è quella di tutti i cittadini miranti al bene comune. I rappresentanti non potrebbero sostituirsi al popolo nell’esercizio di una sovranità del quale il popolo è detentore legittimo. Ma se è escluso che siano loro ad avere l’ultima parola, Rousseau suggerisce però che possano partecipare all’elaborazione della legge. Egli non dice, infatti, che ogni legge che il popolo non abbia votata è nulla. Usa al contrario l’espressione «ratifica» per indicare l’atto sovrano col quale il popolo approva una proposta di legge. Questa ratifica, però, è richiesta assolutamente. Una legge che tutto il popolo non abbia esplicitamente approvato non merita tale nome. Qualsiasi legge sulla quale ciascun cittadino non si sia personalmente pronunciato è illegittima. Traduciamo : una legge che non sia stata approvata per referendum non vale niente.


.png)






